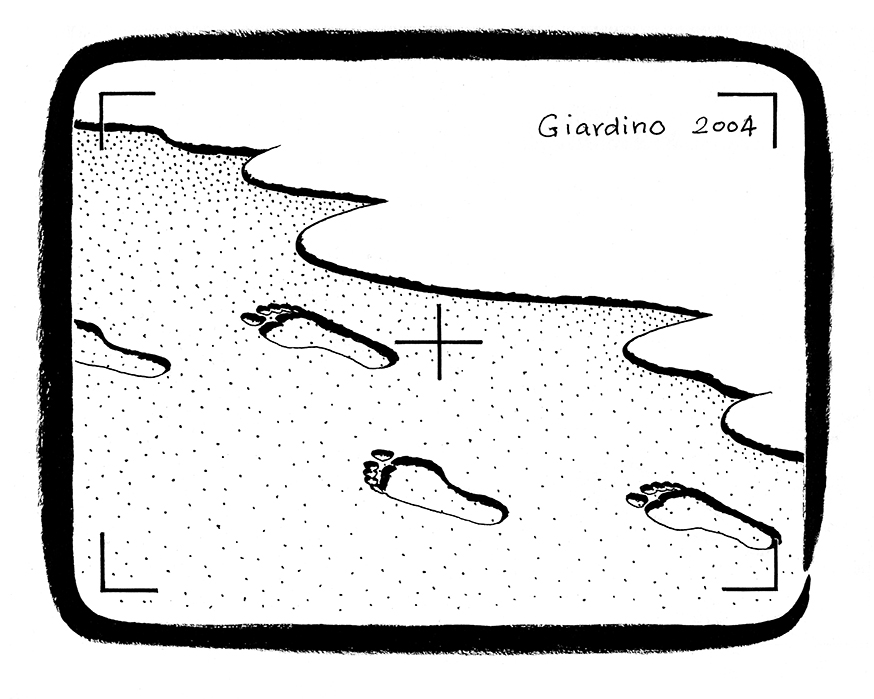Pianeta Calabria
Alberto Frattini
L'universo iconografico di Giuliano e Cesare Di Cola rappresenta un repertorio etnografico che soccorre nella ricostruzione della Calabria della memoria; un lavoro con l'occhio dell'anima, per fissare con uno scatto, su una pellicola sensibile, le immagini, i colori, il senso profondo della terra di Calabria e della sua gente. La tecnica si immedesima con l'estro, con il terzo occhio di poeta, per cogliere le radici profonde di una realtà antichissima, dura e duttile, che si traspone dall'immediato al senza tempo. Così le figure umane, i loro gesti e atteggiamenti - fra accettazione e disincanto, stasi e miraggio - ci trasmettono uno spaccato immaginario e concretissimo di questa forte e dolente, luminosa e amara Calabria.
Carmine Benincasa
Il 6 agosto 1900, in una sua poesia¹, Lou Andreas Salomé scriveva: "chiaro cielo su di me / mi voglio confidare: / non posso tra la gente qui / costruire la mia piccola vita. / Tu che ti estendi sopra il mondo / per ampi spazi e venti / cerca la mia patria tanto desiata / dove possa trovare me stessa. / Non voglio che una sola zolla / per starvi ferma, sicura." Giuliano e Cesare Di Cola hanno ritrovato la loro patria, la loro zolla di terra, la Calabria, e queste foto che lasciano a noi in eredità lo svelano [...] I fotogrammi dei Di Cola confermano che il nostro compito non è di conoscere quello che possiamo, ma quello che dobbiamo. La fotografia aderisce alla carne degli artisti fotografi Di Cola come ad una carta assorbente; il mondo è illeggibile sulla loro pelle, la Calabria è indecifrabile nel loro sguardo di fotografi. I Di Cola si nutrono della vita della fotografia. L'immagine è il loro (in)-finito, la luce dello sguardo sulle cose del mondo li scioglie dal compito della parola. La loro anima aderisce a ogni sillaba di visione, fino a comporre un alfabeto di armonia, un'anima di universo. E con le foto rubano il mondo e diventano "mondi". Basta un pressocché di nonnulla per passare dalla notte al giorno e consegnare a noi il giorno del mondo, insieme alla coscienza del mondo. Le foto sono i segni raccolti dai loro occhi, i suoni pronunciati dalle labbra della natura e dai frammenti dei resti della storia. Una spiaggia ci appare come l'immagine di un sospiro (in)-finito (si veda la foto "Tropea – Spiaggia vista dall'alto"), un laghetto come una frontiera eterna, senza limiti, perché è pura musica (si veda la foto "Sorgente di Nausica"). Nell'immobilità della visione ci restituiscono il movimento secolare del mondo e la coscienza delle radici. Queste foto hanno il profumo dei secoli e il dondolio del presente. L'oblio è sempre fuori dall'universo degli artisti-fotografi. Queste foto sono una lettera al mondo di chi conosce le origini e sa dove vuole andare. Una lettera che non attende risposta. Una confessione breve, ma definitiva, senza parole, con immagini scolpite nello sguardo del cuore. Queste immagini sono i pennelli della speranza di un intero popolo antico, il popolo calabro. Gli occhi degli artisti si aprono al nostro sguardo: insieme, siamo il nostro cammino. Noi stessi siamo il nostro universo, la nostra storia, il nostro presente. La speranza è qui, intorno a noi, nella nostra storia. La nostra storia è immensa ed antica. Siamo i segni delle mani dei nostri padri, siamo le labbra della natura. Siamo la primavera di un antico popolo. Le foto che seguono dei Di Cola parlano di tutto, della natura e della storia del popolo calabro, nello stile grandioso di una antica cronaca: le cose più lontane è come se fossero nel presente, l'avvenimento di un attimo furtivamente rubato dallo sguardo come se fosse inscritto e sigillato da qualche parte nell'eternità. "Il mio paese da tanto abbandonato / il mio paese nell'infanzia sognato, / lo ritrovai sulla mia via / e ora mi congedo in lieta nostalgia", scriveva Lou A. Salomé a Rainer Maria Rilke, pensando alla Russia. Queste foto dei Di Cola fanno balbettare ogni figlio della Calabria, pensando alla sua terra, terremoti di emozioni silenziose. Il tempo della foto è il tempo di una domanda che non attende vane risposte, certifica l'eternità di ciò che lo sguardo vede nel presente. Le fotografie dei Di Cola trattengono il pensiero, così come si trattiene il respiro, per meglio udire il silenzio delle ruote dei secoli che turbinano nel nostro cuore. I Di Cola scrivono su lastre fotografiche di uno stesso quaderno, come su un pezzetto della loro anima. Hanno fatto della Calabria la loro casa dell'anima e la guardano come una violetta del pensiero. Questi due fotografi hanno nostalgia della loro terra. La nostalgia, per loro, non è coscienza dell'assenza, ma presenza forte e intensa. Essi hanno l'immagine precisa dell'infinità solo guardando questo lembo di terra, il cui nome è Calabria. (Prefazione in Visioni e memorie di Calabria, PianetaCalabria 2004)
[1] Manoscritto edito soltanto nel 1992 in edizione francese, poi tradotto nell'ottobre 1994 in italiano dall'editore Bollati-Boringhieri.
Calabria e calabresi nell'Archivio Fotografico di Giuliano e Cesare Di Cola
Mostra fotografica a cura del Centro Interdipartimentale di Documentazione Demoantropologica "Raffaele Lombardi Satriani", Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cs) 2002
«[...] Una rievocazione, perché alcune immagini risalgono al '62, e, per altri versi, una mostra di grande attualità; immagini che ci restituiscono una Calabria del passato, ma che ci offrono, anche, una Calabria del presente. Immagini straordinarie, perché non sono soltanto documenti offerti all'attenzione o alla curiosità del visitatore, ma anche immagini filtrate attraverso una sensibilità da artista». (Prof. Ottavio Cavalcanti in Impressioni di Gianfranco Donadio, puntata del 28/01/2003)
rassegna stampa
La fotografia tra documento storico e testimonianza politica. Il volume-inchiesta del '63 che smosse coscienze e azione amministrativa.
Nel 1963 venne pubblicato un fotoreportage di Giuliano Di Cola nel volume Tam Tam in Calabria del giornalista Franco Scillone. La prima edizione del libro (Arte e Vita, Giffone 1963), premiato best-seller della saggistica meridionale, è diventato ormai "preziosità per bibliofili". La seconda edizione (2004) «risulta rinnovata nella veste tipografica e con qualche modifica e aggiunta nel testo. Il libro è un forte graffiante spaccato economico-sociale sulla Calabria degli anni Sessanta, scaturito da un approfondito e traumatizzante viaggio-inchiesta del giornalista Franco Scillone a San Morello, derelitta frazione di Scala Coeli in provincia di Cosenza [...] Significativo il corredo fotografico che completa il testo e ne diventa eloquente integrazione» (Franco Scillone, Tam Tam in Calabria, Edizioni Prometeo, Castrovillari 2004).
«[…] primi anni Sessanta del Novecento. San Morello già era passato sulle cronache italiane e internazionali come “vergogna d’Italia” perché priva di ogni collegamento con gli altri centri collinari e con la zona litorale, distante circa 6 chilometri, ma anche per la mancanza della luce elettrica, dell’acquedotto, di servizi igienici, un negozio, un medico; per l’arretratezza, l’isolamento e la miseria indicibile della popolazione di circa 700 anime […] Con uno scatto di dignità, gli abitanti di quel paese senza strada decisero di disertare in massa le urne alle consultazioni elettorali […] La protesta, unita al libro-denuncia (Tam Tam in Calabria, 1963) del giovane giornalista Franco Scillone, portò San Morello all’attenzione del Ministro dei Lavori Pubblici Giovanni Pieraccini; ci furono interpellanze parlamentari, discussioni nelle aule universitarie e lo stesso Ministro, a piedi […] accompagnato dai sanmorellesi raggiunse quell’angolo remoto di Calabria, vedendo, promettendo e poi realizzando opere pubbliche come quella via d’accesso che, per una comunità contadina arcaica era soprattutto il diritto all’altrove, a un’altra possibilità […]» (Assunta Scorpiniti, San Morello, il paese del silenzio, in «Il Quotidiano del Sud» del 5 Ottobre 2014)
[...] avvertiamo la necessità di riscoprire la nostra identità, il legame con il nostro "centro storico", dove sono stratificate le "memorie" delle generazioni che ci hanno preceduto, la storia di una comunità di artigiani, di commercianti, di liberi pensatori, che si configuravano con l'essenza stessa della città, che faceva di loro cittadini partecipi e non distaccati dalle realtà delle tensioni umane, politiche e religiose dei loro tempi. E questa necessità di "identità" che spinge Di Cola a riscoprire le fonti pietrificate del suo passato, a percorrere con l'obiettivo fotografico e fissare sulla memoria statica della pellicola le immagini di vie e vicoli, di scalinate che si inerpicano fin sotto il Castello Svevo, di portali di antiche botteghe artigiane, di finestre che paiono "buchi neri", che nascondono arcani misteri di altre dimensioni di spazio e tempo. [...] Di Cola interviene stendendo sull'immagine un diaframma di pulviscolo atmosferico, che ottunde la spigolosità dei muri fatiscenti,ammorbidisce i contrasti del chiaro-scuro, come se le emulsioni materializzassero evocazioni oniriche, emerse dalla profondità della psiche, dove sono memorizzate le esperienze primigenie. Egli scava dentro la città storica, estrapola i particolari, li sceglie accuratamente, spinto anche dai suoi bisogni inconsci, raccoglie e fissa non il "pittoresco", ma quegli scorci della città che possono assurgere a simbolo di una condizione presente, e questo lo induce ad intervenire sull'immagine per darle una dimensione di tempo passato [...] Quasi tutte le sue opere sono da considerarsi oggetti estetici autonomi, ognuno dei quali ha una sua funzionalità in grado di mediare le esigenze consce e inconsce dell'autore e comunicarle al fruitore, il quale, a sua volta, è indotto ad un'attenta analisi dei significanti e dei loro nessi con la realtà soggettiva. Egli utilizza la scienza, la tecnica, per creare l'oggetto estetico, a differenza dei neo-impressionisti, con i quali ha un certo legame (la frantumazione della materia), che utilizzavano la pittura per pervenire alla scienza (ottica). E un processo che esemplifica il mutato atteggiamento dell'uomo di fronte alla tecnica, alla scienza, alle necessità di recuperare una dimensione umana della realtà, che è per Di Cola, innanzitutto, recupero di" identità", che passa attraverso la riscoperta del passato, consapevole che si è cittadini, uomini liberi, quando la coscienza storica individuale si configura con quella collettiva.
A proposito della fotografia e della ricerca espressiva di Giuliano Di Cola
Certamente più d’uno, guardando le immagini di Rende Images, penserà: «Sì... va bene... sono bellissime, originali ma... in fondo in fondo sono solo fotografie!». Come a dire: l’arte è tutta un’altra cosa; e come a concludere: anche un pessimo dipinto ha più dignità artistica di una immagine fotografica. Indubbiamente pesa sulla fotografia, come specifico, l’uso volgarizzato e banalizzato che se ne è fatto e se ne fa in questa nostra civiltà che, in mancanza di una dose sufficiente di razionalistiche motivazioni, si è rifugiata e si rifugia nell’alienata evidenza dell’immagine meccanicamente riprodotta per imporre le proprie verità (o presunte tali); cosi come le pesa addosso quel suo-proprio dato tecnicistico che, come a torto pensano i più, farebbe da oggettivizzante filtro fra il momento dell’ideazione e quello della realizzazione, ovvero fra l’intelligenza dell’operatore ed i meccanismi di fissazione dell’immagine. Residui, in definitiva, questi di croste idealistiche non definitivamente grattate e contradditoriamente combinatesi con una ancestrale diffidenza verso tutto ciò che è “tecnica’’. Comunque, croste o non croste, diffidenze o non, oggi come oggi in fatto di arti visive è per lo meno approssimativo continuare a dare per scontata una sorta di gerarchia fra i generi che non sta né in cielo né in terra e in base alla quale la fotografia sarebbe una sorta di sottoprodotto artistico: ma si tratta piuttosto di individuare nell’ambito dei singoli specifici i sistemi interrelazionali di comunicazione che ogni intervento è in grado di determinare fra l’oggettivizzazione di sé e la controparte, il destinatario; si tratta, quindi per restare in tema di fotografia, di distinguere - senza ulteriormente oziare sfogliando la margherita “è arte o non è arte?” - fra immagini significanti-comunicanti e bagattelle da destinare ai sacchetti a perdere della spazzatura. In una tale traccia metodologica la ricerca espressiva di Giuliano Di Cola diventa veramente esemplare: non a caso le sue fotografìe offrono all'osservatore non tanto quello che l’occhio, seppur iniziato, ha visto, quanto quello che il contesto ritratto ha suggerito di sé al di là della propria oggettiva connotazione e di cui rintelligenza e la sensibilità si sono potute appropriare, esprimendolo, per via intuitiva e non certo tramite il solo “mestiere”. Di Cola, insomma, sottrae la fotografìa ad ogni evidenza documentaristica dandole una capacità interpretativa strutturata su segni preva lentemente poetici. Si, è vero, tali segni (le inquadrature, i tagli, i rapporti spaziali, la luce, e, soprattutto, le inquietanti alchimie in camera oscura) hanno un dato di partenza di affìnatissima professionalità: ma è altrettanto vero che questa professionalità trova il suo momento di decantazione nella costante tensione di cavare dall'immagine tutte le sue più interne significazioni. E come risultato si ha che non è la tecnica strumentalizzare o, almeno, a condizionare l’intelligenza e la sensibilità dell’autore ma è esattamente tutto l’opposto. Basti per tutto l’uso delle retinature. Nel caso della precedente mostra di Di Cola “l’altra città” - dedicata a Cosenza Vecchia - tali retinature stendevano sui luoghi di un territorio in degrado oltre che rassegnato al proprio squallido destino di decadenza, una patina di intriso squallore; invece in queste immagini di Rende - ove il centro storico costituisce il cuore pulsante di tutto il tessuto urbano - esse esaltano l’identità urbanistica e ancor più socio-culturale di una comunità che ha preso coscienza di che cosa significa per il proprio presente e per il proprio futuro vivere senza recidere i legami con la propria memoria storica fatta anche e soprattutto di antichi muri che parlano. Per cui “Rende images”, quella che in termini di puro e semplice oggetto ritratto è, ad esempio, solo e soltanto una finestra chiusa su un cortile, tramite l’intervento fotografico di Di Cola si carica di allusioni e di rimandi e diventa un varco spalancato attraverso il quale è possibile penetrare in una ben precisa dimensione di vita con tutto il suo spessore di vissuto che è stratificazione secolare di collettiva quotidianità.
La poetica dell'immagine dei Di Cola si fonda su attività percettive di sottile sensibilità, sorrette dal supporto di un forte potenziale autentico verso il particolare.
[...] Poeta come sa essere, Giuliano Di Cola avrebbe potuto sciogliere un inno a Cosenza e avrebbe potuto cantarne fatti, vicende e personaggi. Ha preferito invece chiedere alla fotografia l'ausilio determinante che nelle sue mani diventa essenzialità. E l'ha percorsa in lungo ed in largo. L'ha rivissuta facendo parlare, più e ancor di più delle carte, l'apparente immobilità delle immagini. Che sono bellissime nella loro dignità del tempo passato. Del tempo che fu. E la fotografia di Giuliano Di Cola come per incanto riesce ad annullare i segni del tempo che deteriora la bellezza ed esalta i segni del tempo, che di questa bellezza colgono l'essenza, quella che supera i confini del tempo e dello spazio. Una fotografia che parla il linguaggio della memoria non come mummificata nella freddezza di un museo ma come palpitante di vita e scoppiettante di vitalità. Una fotografia che penetra nella essenza della realtà a coglierne l'anima. [...] Fotografie come sonetti che cantano un inno d'amore.
Cosenza antica in un discorso per immagini dovuto all’obiettivo, meglio dire all’occhio di Giuliano Di Cola. Marchigiano di Ascoli Piceno trapiantato in Calabria, è qui a Cosenza, che Di Cola, questo operatore fotografico dotato di una sensibilità pronta come un radar alla scoperta dei “valori” visivi a contatto con l’antica civiltà bruzia, nei suoi echi secolari e nei suoi eterni ritorni, dopo varie esperienze professionali e dopo numerose partecipazioni alle più qualificate rassegne fotografiche in Italia e all’estero (prima, fra tutte, la Biennale internazionale “Fotografi della nuova generazione” alla galleria d’arte di Milano e al Museo d’arte moderna di New York), scopre nel linguaggio della fotografia come arte un messaggio ben più profondo e credibile delle parole. Strutturate sulla base di un armonico (e armonioso) tracciato di linee e di punti, intesi, questi ultimi, come frammenti disintegrati di un bell’equilibrio di spazi pieni e vuoti; di una felice partitura d’ombre (il tutto ottenuto grazie all’impiego della retinatura sulla memoria statica della pellicola: una pratica che eccita ed esalta l’uso della camera oscura e della bacinella di sviluppo), queste di Di Cola (delle quali qui non si presenta che un piccolo saggio) sono immagini che nascono dall’amore e dalla frequentazione assidua di Cosenza - quella tale e circoscritta città -, che ad un estraneo e superficiale osservatore appare ostile e malinconica, un nucleo urbano in lento ma inarrestabile declino nello squallore degli edifici, nella rovina degli intonaci, nelle trame degli approdi. Non così a un innamorato delle bellezze segrete, qual’è Giuliano Di Cola, che, memore attento delle vestigia di un tempo splendido e vivo, custodisce gelosamente ogni angolo, ogni luce di questa eterogenea e pur così compatta “città di pietre”. I piccoli spazi prospicienti alle case padronali, gli estradossi dei ponti, i ballatoi, le scalinate a perdifiato spesso segnate da grandi archivolti, il lastricato dei cortili e delle stradine erte e strette, i vicoletti senza orizzonti e dalle pareti incombenti, assumono nell’immagine di Di Cola un palpito di memoria, meglio, un sapore di palinsesto, come se nascoi dessero trame complesse e cifrate delle vite che si sono consumate per quei vicoletti, quelle stradine e quelle scalinate, in quelle case e su quegli spiazzi, cortili, ballatoi. Bisogna risalire, attraverso l’opera fotografica tutta intiera di Giuliano Di Cola su Cosenza antica, pagine di storie del costume che ha qui, nella “città alta”, il suo epicentro, ma che si estende con rilevanti variazioni a tutti gli antichi centri urbani piccoli e grandi del nostro Mezzogiorno, simili con diversi distintivi ma con una comune ancestrale radice: un costume marginato, non soltanto dalle difficoltà della sopravvivenza nell’incalzante ritmo dei consumi e del profitto, ma soprattutto dalle radicate convinzioni, conficcate nei secoli oscuri dell’inquisizione, e oggi divelte, e fors’anche beffeggiate, dalle nuove generazioni che si affrettano a cancellare il retaggio - che diventa onta - del moralismo meridionale. Giuliano Di Cola è un uomo tranquillo, serio, meditativo. Il suo mestiere di fotografo è fatto di precisione, di rigore, di esattezza, soprattutto di scrupolosità quanto alla fedeltà dei toni in relazione alla reale consistenza delle luci. Le fotografie, si sa, falsano i colori, da una sorte di miraggio, sull’accesso, e i fondi prendono il giallo, il rosso, il blu. Qui no. Di Cola sceglie - ed è raro privilegio - le tonalità care a Shelley: le tonalità sfumate dell’umido, della muffa, degli intonaci, dei legni smorti delle porte, la porosità delle pietre che vanno ad incorniciare i portali, l’oscurità soffice intravista dalle porte e dalle finestre, l’unto del fumo di carbone lasciato dai fuochi agli angoli delle case..., ed opera il più vero e affettuoso ritratto di Cosenza. È un ritratto soltanto affettuoso, o un’analisi accorata, e, perché no?, impietosa, delle condizioni in cui versa una parte di Cosenza? Di Cola non può certo aver conosciuto, data la sua appartenenza ai nati della generazione che sta superando ora la più scoperta giovinezza, la vita fastosa d’orpelli e delle “proprietà” fittizie, nominali, che la prima guerra mondiale spazzò via e, con la bonifica del vallo, aperse l’accelerata costruzione della Cosenza del secondo dopoguerra. La nuova condizione ha portato potere, commercio e un soffio di imprenditoria moderna. E questo, tutto questo, è ancor oggi contrastato dalle coriacee tradizioni che da sempre caratterizzano il meridione d’Italia. Di questo pervicace attaccamento delle generazioni tardive Giuliano Di Cola può essere considerato un simbolo, ma le sue immagini non tendono a nobilitare le facciate fruste e i portali smozzicati, viceversa stanno ad indicare semplicemente le rovine che il empo e le negligenze degli uomini provocano in questo aggregato urbano, poco più delle dimensioni di un quartiere o d’un “rione” circoscritto nella toponomastica cittadina, che però è l’unico a rappresentare la storia e l’umanità di Cosenza. Quali virtù e quali palesi aspetti di una realtà che Giuliano Di Cola indaga e rivela sono palpitanti nella realtà d’oggi? Si riporta dalla tradizione e dalle voci, che hanno spesso conferma, che gli interni delle case gentilizie della città antica di Cosenza siano ancora ricchi di vestigia, architettoniche e murali, testimoni di un fasto e di una cultura segreti, in contrasto con le facciate austere e guardinghe che dovevano mostrare al popolo (e anche a sé stessi) un carattere ligio alle severità dei costumi, del sobrio disprezzo delle pompe e delle vanità, della ferma religiosità nelle forme. Non c’è dubbio che Di Cola non ha voluto significare con le sue immagini certi enigmi della vetusta civiltà cosentina, piuttosto, ecco, raccontare il suo splendore, nonostante l’evidente e il denunciato degrado. Ma i suoi esiti fotografici, più che delle testimonianze narrative, vogliono essere, al di là dei loro valori intrinsechi di livello culturale, dei documenti che stabiliscono il punto focale di Cosenza antica, in questo tempo e in questa temperie. L’appassionata maestria di Di Cola è lievitata da un più alto respiro; il lirismo della poesia dialettale passa nell’universale senza più sfiorare il provincialismo - la poesia delle “antiche città” che languono in ogni contrada europea, nei centri soffocati e obliterati delle grandi città, al pari degli antichi villaggi abbandonati, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Scozia e, ancor più, da noi, in questa nostra Italia così sorda e sazia di bellezza, così indifferente alle cento Cosenza che espongono le loro piaghe all’inquinamento, allo smantellamento, al brutale riassetto che le snatura e le riforma-. No, non è piccolo, e non è poco, il risultato raggiunto da Giuliano Di Cola, tn solitudine, o con la sola compagnia della fiducia nelle indicazioni dell’autocritica. Egli ha acquisito un proprio ben riconoscibile linguaggio lungo l’ormai noto, e notevole, percorso di operatore fotografico; la sua vocazione naturale di lirica consapevolezza di intensa sensibilità non è mai stata tradita, onde il procedere è stato ed è costante, segno di una personalità fermamente definita.
"Eredità del passato" di Giuliano Di Cola
L’“Eredità del passato” è il titolo di un’opera di Giuliano Di Cola, edita da Effesette per conto della Banca Popolare di Calabria, presentata a Cosenza nel salone della Camera di Commercio. La si può definire un contenitore, visto che si compone di un volume nel quale sono pubblicati lo studio storico (con elenco di uomini celebri) sulla “Calabria Citra”, tratto dal “Viaggio nel Regno delle due Sicilie” di Fortunato Stancatone, pubblicato a Napoli nel 1848; un brano dello scrittore Beniamino Fioriglio, dal titolo “Solitudine del presente”; un profilo dell’artista e della sua opera dal giornalista d’arte Raffaele Mazzarelli; un piccolo “assaggio” della vasta produzione fotografica con la quale Giuliano Di Cola ha fermato il tempo nella Cosenza antica. Di fronte ad un pubblico qualificato, presente l’artista (le cui opere erano state esposte nella vicina galleria “Il Triangolo” di Enzo Le Pera)...., il collega Pino Nano ha saputo, comp sempre, determinare il clima che più si conviene ad un dibattito, offrendo a Ernesto Marano, Ernesto D’Ippolito, Fulvio Terzi e al sindaco di Cosenza Giuseppe Carratelli, l’occasione di ribadire le rispettive posizioni sul problema della rinascita .e della valorizzazione del centro storico. Sui mali di Cosenza vecchia si sono versati fiumi d’inchiostro; si sono accapigliati politici d’ogni colore; si sono accumulate promesse su promesse. La verità su ciò che è stato fatto e su quello - molto, molto di più - che rimane da fare, affinché nella Cosenza antica torni a pulsare in modo più intenso la vita, è sotto gli occhi di tutti. Non dimenticherò mai il pianto di Fortunato Seminara che mi volle per compagno durante una delle sue ultime visite cominciata partendo da una delle strette viuzze medioevali che s’affacciano- su Piazza dei Valdesi. E se non possiamo esimerci dal sottolineare gli appelli di D’Ippolito e Terzi e gli impegni di Carratelli, dobbiamo plaudire all’iniziativa della Banca Popolare di Calabria che, come spiega nella presentazione del volume il presidente Ernesto Marano, ha inteso sponsorizzare la pubblicazione proprio per recuperare la memoria storica, facendo così, secondo noi, un’operazione di alto valore culturale nonché civile e morale. In modo da testimoniare sensibilità ed interesse per questa parte della città che spesse volte è salita anche agli onori della cronaca nazionale; senza però essere stata mai capace di stimolare concretamente azioni in grado di rimuovere le apatie e le indifferenze. E se è vero infatti che il degrado delle strutture di Cosenza vecchia è, purtroppo, inarrestabile ormai da oltre mezzo secolo, è vero anche che - come scrive lo stesso Marano - il ricordo di quando era “la Città”, almeno per coloro che vi hanno trascorso la fanciullezza, resta indelebile. E il merito di Giuliano di Cola è quello - conclude Ernesto Marano - di offrirci la possibilità di riflettere, con l’arte delle sue immagini, e fare in modo che I’“Eredità del passato” possa ancora essere tramandata alle generazioni future. Ma chi è Giuliano Di Cola? “Un uomo tranquillo, serio, meditativo” - scrive Mazzarelli - il cui mestiere è fatto “di precisione, di rigore, di esattezza, soprattutto di scrupolosità”. La fortuna di Di Cola, secondo me, è stata quella di non essere nato a Cosenza, ma ad Ascoli Piceno; e di avere quindi visto, come una creatura fuori da se, con gli occhi dello “scopritore”, il complesso architettonico che costituisce il centro storico di Cosenza. Ancora a misura d’uomo; dove la vita quotidiana era contrassegnata dai rapporti tipici del buon vicinato. Quando le porte neppure si chiudevano: non solo per lasciare entrare il sole (soprattutto nei bassi e nelle case degli stretti vicoli), ma perché, ciascuno potesse godere delle gioie degli altri e piangere anche i morti. La particolare tecnica usata da Di Cola nella fase di sviluppo e stampa dei suoi lavori contribuisce notevolmente a dare l'immagine di una Cosenza che non è più, purtroppo. Dall’apparente staticità degli scorci panoramici, fissati dall’obiettivo della fotocamera, sembrano staccarsi figure di donne che s’affacciano sull’uscio di casa, tenendo, a cavalcioni su uno e entrambi i fianchi, oppure normalmente in braccio, uno, a volte anche due bimbi; e nello stesso tempo, dando voce, per far sentire la propria vigile, affettuosa presenza, agli altri figlioli più grandicelli intenti a giocare attorno alla fontana sulla piazzetta. Dalle finestre di un’altra abitazione sembra di sentire il lamento di una moglie nelle cui braccia è appena spirato il giovane consorte: morto di malattia, però, e non vittima di un agguato con le più comuni armi da fuoco o con la lupara o, peggio ancora, con uno di quei micidiali e più sofisticati strumenti di morte oggi purtroppo assai di moda perché facilmente reperibili non soltanto al mercato nero. E come non sembra vero quel Corso Telesio di Giuliano Di Cola il cui silenzio senti che è rotto (lo senti se chiudi gli occhi e spalanchi il cuore, ponendoti nella condizione di chi è disposto ad ascoltare le voci di dentro...!) soltanto dal rumore cadenzato dei passi di chi Io sta percorrendo come svagato, non essendo stato -beato lui! - neppure sfiorato ancora dalla frenesia tipica del più deteriore consumismo che non risparmia ormai quasi nessuno! La Cosenza vecchia di Giuliano Di Cola, in fondo, vive una sorta di intima battaglia; uno scontro vero e proprio; un conflitto come tra due personalità, due modi di intendere la realtà. Nel faccia a faccia tra chi desidera fermare il tempo e, quindi lasciare le cose come stanno, in modo che il degrado faccia il suo corso naturale; e chi invece vorrebbe arrestarlo il degrado e riportare la vita laddove ormai aleggia l’inarrestabile processo di disfacimento, che porterà al punto del non ritorno, al coma irreversibile e quindi alla morte del corpo e, quel che è peggio dell’anima, ossia della memoria storica. Chi vincerà la guerra? L’interrogativo, almeno per ora, rimane senza risposta. Perciò, nel frattempo, noi che riusciamo ancora a commuoverci alla vista di un bel panorama e che, come Fortunato Seminara, ci abbandoniamo al pianto di fronte allo scempio provocato dalle umane miserie, noi, almeno finché possiamo, godiamoci le meraviglie che ci mostra Giuliano Di Cola!
Memorie di un mondo sommerso
Le immagini ci assediano. Sparate, potenziate, iterate ai limiti del demoniaco dall’elettronica, dirette sulle nostre fragili vite schizoidi da schemi implacabili, inseguono e braccano l’occhio che si serra alla ricerca del vuoto-buio-tutto bianco-tutto nero. Dove non arriva l’elettronica arrivano le macchine fotografiche, sempre più piccole, più facili da usare, sempre pronte in ogni tasca, buone annulla e capaci di tutto. Gli uomini e le cose non esistono più se non mediati attraverso scatti e riprese, trilioni di immagini ormai ci ossessionano con la loro falsa verità di “documenti”. Le immagini seguono le leggi della moneta, si inflazionano, si sviliscono, quelle cattive scacciano le buone. Basta, dateci requie, o dateci buoni fotografi. Viaggiatori provenienti da più parti riferiscono che ne esistono ancora. Fotografi veri, con occhio e cuore d’uomini. Giuliano Di Cola è uno di questi. Da tempo si è sottratto alla tentazione e alla condanna di documentare, di offrire un anonimo occhio di vetro bon à tout faire per veggenti distratti e confusi. Dalla fotografia, intesa come un processo unitario che va dall’inquadratura alle manipolazione di stampa, ha fatto un irripetibile scandaglio-sonar capace di trarre da una prospettiva un fascio di informazioni emotivamente rilevanti. Un arco sbrecciato, una scalea corrosa, un androne ricco solo d’erbe inselvatichite, una maschera o un antico gesto legato a mestieri in via d’estinzione, sondati con lo scandaglio-sonar di Di Cola riversano segni precisi e netti, una storia, che è sempre storia di uomini, come si sa. Di Cola non ferma i propri soggetti, li spia e li offre ancora vivi. Di fronte ai suoi lavori, anche in tempi di infrazione visiva, è il caso di aprire gli occhi e di lustrarseli.
Memorie di un mondo sommerso
Questa ricognizione fotografica realizzata da Giuliano Di Cola; marchigiano di nascita, ma bruzio di elezione, non è una mostra di cose morte, ma una visione fantasmagorica della “civiltà contadina” calabrese, rivisitata con intelletto d’amore da un poeta della luce e da un artista che sente il passato della nostra gente senza pateticismi pseudo romantici ma come ancestrale memoria d’infanzia emergente da un paesaggio tormentato come l’amore, come la fatica e la pazienza. Giuliano Di Cola osserva la terra e le cose, le opere e i giorni della nostra regione con la medesima intelligenza dello storico che, mentre scorre con l’occhio la pagina stampata, non dimentica che que sta prodigiosa invenzione deriva le sue remote origini dalla trasformazione gutenberghiana del torchio dei vignaioli renani in torchio da stampa e che quest’ultimo, circa mill’anni prima, del 1460, aveva avuto il suo antesignano in quel torchio da vino, introdotto dai romani nel paese natio di Gutenberg, al quale può aspettare anche il vanto di essere stato l’iniziatore della rivoluzione industriale, che storicamente, ha i suoi incunaboli, nella sostituzione della macchina al lavoro degli amanuensi. Vogliamo dire che nella indo vinata successione figurativa delle foto-sequenze di Giuliano Di Cola il senso del passato e della morte è riscattata dalla memoria dell’osservatore che nelle immagini del passato avverte la misteriosa corrispondenza dell’effimero e dell’eterno nella corsa perenne del divenire eracliteo. È questo di Giuliano Di Cola, quindi, un viaggio assolutamente immune di ogni morbosa dilettazione vitti mistica, goduto e sofferto con la curiosità discreta dell’osservatore sensibile e del ricercatore aperto a cogliere i segni più silenziosi della “civiltà contadina” scritta, senza retorica, nelle rocce e lungo le fiumare con l'alfabeto dei solchi, alla scuola della rassegnazione, ch’è la forza invincibile degli oppressi. Queste immagini tolgono alla dimenticanza le memorie del “mondo sommerso”, e mentre danno nel breve spazio di un “ritratto” un’atmosfera trasognata al quotidiano, pur così duro e crudo, della vita contadina, contemporaneamente, fissano nella verità del fotogramma, quei valori intramontabili di una civiltà radicata nell’inconscio collettivo percepito ancora nella moralità di alcuni rituali di cristianesimo arcaico superstite nel gesto della madre che fa la pasta in casa assottigliandola con misericordia fra le dita “come se in quel momento avesse pietà di tutto il mondo senza pane”, o quell’altro rituale pagano dell’uccisione del maiale, che, a distanza di secoli, ancora adombra e ripete l’offerta cruenta a Giove oscuro e nemico. Attraverso la luce della lente fotografica di Giuliano Di Cola, dun que, ritorna viva sotto i nostri occhi quella remota esperienza di vita paesana e campestre, oscuratasi dentro di noi, ma sempre pronta a ridestarsi sotto l'urto assordante del macchinismo pro gressivo, che proprio nel Sud più profondo mostra soltanto il suo volto più deludente e disumano. Vogliamo dire che questa sommessa, silenziosa “fotologia” Di Giuliano di Cola, non riesce né a nascondere, né a sorvolare sull'angoscia di un intero popolo, quello calabrese, nel quale ogni calabrese “verace” si riconosce e in esso «riscontra la propria analo ga condizione: quella continua sofferenza, collettiva perpetua», «quella sofferenza della propria infanzia» che ha intriso anche il cuore del geniale fotografo Di Cola, come quello del grande poeta sambiasino Franco Costabile, che avvertiva sempre in sé «un rivolo arso di amarezza», di cui non sapeva o non riusciva a liberarsi, anche se “il rivolo di amarezza” del Di Cola non è stato, al contrario del poeta Franco Costabile, una sua libera scelta e, quindi, il foto grafo, per quanto ricco di risorse, non se la sente di diventare una di quelle «giacche appese nelle baracche nei pollai d’Europa» e nep pure di sentirsi, anche lui, come il poeta, «una rosa nel bicchiere».
Uomini e fatti
Di Cola e il mondo sommerso
Corrado Alvaro, Franco Costabile, Enotrio, Giuliano Di Cola; uno scrittore, un poeta, un pittorè, un fotografo, tutti messi insieme da un comune denominatore, la Calabria del mondo sommerso, la Calabria della memoria, la Calabria terra di lavoro agricolo, di passioni ancestrali. La mia Calabria, quella che non mangiava pop corn, non ruminava chewing-gum, non beveva Coca Cola. Affascinato dalla prosa del sanluchese, dal verso del sambiasino, dal colore del sancostantinese, non ebbi conoscenza d’un cantore al nitrato d’argento di quella Calabria, fino a quando, per puro caso, in una Tropea inondata di sole primaverile, non conobbi Giuliano Di Cola, il fotografo marchigiano adottato a Cosenza, che meglio d’un calabrese ha saputo cogliere lo spirito dell’Old Calabria che qua e là ancora resiste. Allora feci personale esperienza della sindrome di Stendhal, il malore che coglie quando ci si trova dinanzi una folla di capolavori e il tempo per vederli con comodo tutti ti manca: capogiri, sudore, respiro breve. Non di rado si sviene. Di Cola aveva il cofano dell’auto pieno di fotografie da lui scattate durante un non breve arco di tempo e lungo un itinerario calabre se che a me dava l’impressione d’essersi sviluppato attraverso le vie del mio ricordo, del mio preterito, al punto che non so quanto scherzosamente, mentre scorrevo le le immagini di quel film conta dino, dissi a Di Cola: «Tu devi essere sincero, devi dirmi la verità. Non temere, non scomoderò la legge, non pretenderò restituzioni, non vorrò compensi, ma la verità sì, la voglio, devo sapere con quali sortilegi tu sia riuscito a penetrare nei recessi della mia memoria e con quel tuo sofisticato apparecchio fotografico ti sei impadronito di tutte le immagini del mio, ahimè, troppo remoto passato chi vi tenevo gelosamente conservate. Mi hai rubato, per renderle pubbliche, le visioni della Calabria della mia infanzia, del mio paese natio dove tornavo ogni anno per le vacanze d’agosto e d’ora innanzi, quando avrò bisogno di ricordare sarà alle tue foto che dovrò ricorrere, perché hai saccheggiato la mia memoria lasciandola completamente vuota. Mi hai portato via tutto, i visi dei nonni, degli zìi, dei cugini, degli amici, dei conoscenti uomini e donne, giovani ed anziani tutti con le stigmate del lavoro e del sacrificio sul volto, sulle mani, nel fisico contorto come il legno dell’ulivo... Mi hai preso gli ulivi con l’argento e le cicale; il sole rutilante e cocente sopra la campagna con le quaglie nella restop pia; le siepi di fichidindia o di canne al vento; il pasto parco ed affrettato nell’ombra sotto la pergola dell’uva zibibbo; il volo della pula sull’aia e l’asino vicino in attesa del carico di frumento o di cereali del tutto mondi; il pane nel forno che spandeva fragranza su tutto il paese; il sapone fatto con la soda caustica nell'antro nero del focolare; la preparazione della conserva di pomodori e poi messa ad asciugare sotto il bacio ardente del sole; la festa del Santo Patrono: i mostaccioli di Soriano, gli argagnari di Gerocarne, la banda musicale sul palco illuminato a carburo, le donne in costume, gli uomini contadini anche sotto il vestito nuovo di fusta gno od orbace che li impacciava, sul petto le medagline dei santi andati a venerare in lontani santuari; il sorbetto o la granita «pian gete ragazzi che la mamma ve la compra!»; i fuochi d’artificio sul cielo con la luna...Mi hai preso Natale, Pasqua, Carnevale, il fidan zamento ed il matrimonio dei cugini e delle cugine, persino i pensieri che attraversavano la mente delle vecchie sedute a filare sugli usci e degli uomini che sognavano un riscatto al di là dell’Oceano perché troppa sofferenza c’era, troppi sacrifici, troppi abusi di potenti e prepotenti, troppe lacrime di rabbia e gridi di ribellione a stento trattenuti...». Ma forse questo lungo discorso non lo pronuncai, mi limitai a pensarlo e sono lieto oggi d’averlo scritto perché Giuliano lo sappia quanto io l’ammiri e lo stimi.
La memoria e gli altri
Cera una volta la civiltà contadina calabrese. E se qua e là ancora se ne rinvengono tracce, esse, sempre più rade e sempre più mar ginali rispetto ai nuovi modi di vivere, sono solo sopravvivenze d’un terragno mondo la cui identità storico-culturale ormai appartiene, o meglio dovrebbe appartenere alla memoria collettiva. Piuttosto, quel che sconcerta è che a parlare di tale mondo si abbia veramente la sensazione di andare indietro di anni luce tanto esso appare lontano. Eppure è storia di appena ieri! Ma tant’è: uno può star fermo per anni, magari per secoli, perché non ha coscienza d’aver gambe simili a quelle degli altri; e quando se ne rende conto, è capace di mettersi tutt’a un tratto a correre a perdifiato; e se lo fa è più per scappare da qualcosa che per arrivare chissà dove. Da qui tanti nodi irrisolti. Scriveva nel ‘50 Corrado Alvaro: «...E’ una civiltà che scompare e su di essa non c’è da piangere, ma bisogna trarne, chi c’è nato, il maggior numero di memorie ... altrimenti si assiste a quei trapassi di civiltà che son sempre sgradevoli a vedersi quando ci si libera dei vecchi vincoli senza capire la natura dei nuovi...» Ma il trapasso c’è stato e, purtroppo, proprio nei termini sgradevoli paventati da Alvaro; e, in definitiva, non poteva non esserci consi derata la storia, nostra e non, di questi ultimi quarantanni. C’è pure oggi la civiltà contadina calabrese, ed è quella nei musei, nelle biblioteche, negli archivi, e che in fatto di riferimenti visivi, puntualmente evoca un campionario iconografico ormai codificato ed alla lunga diventato di maniera nel suo drammatizzante simbo lismo; quasi che questa stessa civiltà, incatturata nella sua secolare tragedia — ovvero: ideologicamente enfatizzata nei suoi nodi problematici —, fosse comunque negata ad ogni sorriso , colore, superfluità anche formale. Muri consumati da un’atavica indigenza, volti segnati dalle stim mate dell’emarginazione e del bisogno, schiene curve a gettare il sangue sulla terra per cavarne il niente, scialli neri, fascine sulla testa, stanchezza antica in groppa all’asino, attesa sulla soglia di un antro senza luce... In fondo, gli stessi... diciamo «stereotipi» che si ritrovano in questo reportage di Giuliano Di Cola: solo che la civiltà contadina calabrese che lui propone è «altra» da quella alla quale — forse per pigrizia mentale, forse perché vittime di schematismi e semplificazioni, forse per altro — ci siamo via via assuefatti. Sì, la sua secolare tragedia è sempre presente, ma non è più un’ossessiva fattura che impedisce, appunto, ogni colore, sorriso, superfluità: è solo un fondo di tristezza, oltretutto espresso allusi vamente; ha sempre i suoi stracci ed i suoi scialli neri, ma essi non son più emblemi di una malasorte collettiva, bensì i segni di una dimessa quotidianità, vissuta come tale e con estrema dignità; i suoi muri, archi e pareti ormai delimitano, sì gli spazi di un vivere desueto nella sua arcaica tradizionalità, ma seppur sempre immi seriti dall’indigenza, rivelano equilibri architettonici e spaziali rustici, rozzi e comunque insospettati. E, poi, i gesti denotano tutti un che di rituale che sa di liturgia del quotidiano; i volti hanno la compostezza di una pensosità senza affanni; gli oggetti addirittura si offrono come elementi compositivi di impensabili nature morte... Insomma, uomini e cose, i medesimi che per altri, in altri tempi, sono stati, perché lo erano, i simboli di un dramma collettivo consumatosi in secoli di storia, a senso unico in questo reportage si ritrovan filtrati da ogni miseria, dolore, fatica e come ricomposti in una trasognata metaficisità. Ma... perché tutto ciò? E dove son finite non solo le lunghe ombre, ma anche le solari luci e l’identità e l’anima vera della civiltà contadina calabrese? Viene spontaneo rispondere con alcuni versi di Franco Costabile, il cui tragico destino è tutto ancora da decifrare nelle sue laceranti interrelazioni con tali luci e tali ombre: «Mio sud / inverno mio caldo / come latte di capra / già si dorme fratello e sorella / senza più gusto. / Mio sud / pianura mia, mia carretta lenta / anime di emigranti / vengono la notte a piangere sotto gli ulivi / e domani alle nove / il sole già brucia / 1 passeri / a mezz’ora di cammino / non hanno più niente da cantare...». Il che per dire che nel reportage di Giuliano Di Cola sono assenti tanto i documentarismi da «Tranche-De-Vie» quanto le rimasticature antropologiche; e lo sono per precisa scelta stilistica perché egli, Di Cola, sotto qualsiasi cielo si ritrovi con la sua macchina fotografica fra le mani, qualsia si idea debba tradurre in resa con le sue intriganti alchimie in camera oscura, intuisce e propone una lettura sempre in chiave di umori sotterranei ed atmosfere in cui è possibile rintracciare il senso vero di una realtà, di un vissuto, di un evento, al di là delle apparenze, al di là delle ufficialità. Ed è sostanzialmente fatto di umori sotterranei e di atmosfere anche questo reportage sulla civiltà contadina calabrese che è, in fondo, una cantata per immagini alla Frederick Rossif, tanto per richiamare una «certa» poetica visiva. Ergo: Di Cola non ha potuto né voluto evocare i fantasmi di un mondo la cui vera identità è, al più, un fatto di memoria o, per altro verso, di studio a posteriori; ne ha ritrovato, questo sì, le poche tracce rimaste e, col suo proprio modo di far fotografia, le ha riproposte in filigrana per fermare il profilo sempre più vago d’una civiltà che sopravvive a se stessa, laddove sopravvive, e che, pertanto, è ormai fuori dalla convenzionale nozione del tempo. Perché la storia, con le sue angosce, le sue passioni, i suoi sudori, la sua spinta ad andare avanti, cambiare, migliorare, per il mondo degli «altri» non esiste più, è capitolo chiuso; chiuso male, ma comunque chiuso, definitivamente. Ed i sopravvissuti, abitanti di un’isola non felice ma per lo meno acquietata, possono ormai permettersi la distaccata serenità di chi ha concluso il suo ciclo vitale, o meglio, storico e non ha più niente da perdere o da guadagnare dal cambiar abitudini e condizione. Per cui continuano a mungere le pecore, a zappare, ad andare all’acqua come hanno sempre fatto; a stringere fra le mani il libro delle preghiere con l’affidamento di sempre, a sferruzzare sulla soglia di casa, ad ammassare il pane e a ripetere tutti gli altri rituali gesti del giorno dopo giorno: solo che ora lo fanno senza più assilli, né vergogna, né rabbia e nemmeno rassegnazione. Lo fanno perché va fatto, perché è stato da sempre fatto e... sia quel che sia! Il vecchio carro funebre è abbandonato in un canto. La comare secca non mette più paura a nessuno: è diventata anch’essa un’abitudine mentale. «La morte ha camminato a lungo per il paese della povera gente, senza troppo volere, senza troppo pensare...».
Quel fantastico mondo che fu. Una splendida antologia di immagini di Giuliano e Cesare Di Cola.
Nel vertiginoso evolversi, ma anche omologarsi, della società contemporanea, i "tesori della tradizione" rischiano di essere emarginati se non proprio di fatto cancellati. Eppure mai come oggi c'è una pletora di pseudocultori del passato, che riescono ad inventarsi anche tornei di Palio mai esistiti e a sfornare come nostrane pietanze forastiere; come purtroppo persiste una dissennata invadenza edilizia frutto più di incultura che di maestria (se ne vedono mostruosi esemplari sulle coste e in cima ai colli), per nulla rispettosa non dico dell'habitat e del passato, ma anche della decenza e del buon gusto. Per ricostruire questo mondo in via d'estinzione il ricorso alle memorie non è certo sufficiente. Soccorre, per fortuna, l'universo iconografico di Giuliano e Cesare Di Cola padre e figlio intenti a fermare momenti e figure del mondo contadino rurale e artigianale, più "con l'occhio dell'anima" che con la macchina fotografica, come ha scritto Alberto Frattini. Un mondo che balza trasparente attraverso le nitide suggestive immagini raccolte e sobriamente chiosate nel volume "Tesori della Tradizione" (della collana "Pianeta Calabria", ideata da Cesare Di Cola), Cosenza 1998, pp. 122... Vengono scanditi i tempi della semina e del raccolto, dell'allevamento e della pesca, del pascolo e della mungitura. Anziani e giovani alle prese con i frutti di sempre e le conserve di oggi, pensosi i primi, giulivi i secondi di fronte al perenne succedersi delle stagioni, anche esse sublimate nei frutti e nei lavori della terra in uno scenario ancora vivo in molti angoli della Calabria, che pare sublimarsi tuttora di miti e riti arcaici, laddove il tempo sembra essersi fermato non si sa davvero per quanto. Una autentica antologia delle immagini e della memoria, che dovrebbe - ci auguriamo - circolare anche sui banchi della scuola per alimentare le nuove generazioni le quali corrono il rischio di perdere quelle radici e la propria identità.
Rende - È stata inaugurata ieri, all’Aula Magna dell’Università della Calabria, la mostra fotografica “Calabria e Calabresi nell’archivio fotografico di Giuliano e Cesare Di Cola”, il cui allestimento è stato curato dai professori Ottavio Cavalcanti, Rosario Chimirri e Gianfranco Donadio, del Centro Demoantropologico, su progetto dello stesso professor Ottavio Cavalcanti che ha provveduto a ricercare e selezionare le immagini. Le foto resteranno in esposizione solo fino a domani. Giuliano e Cesare Di Cola, padre e figlio, uniti anche dalla passione per l’arte fotografica, collaborano insieme alla formazione di un vasto archivio fotografico (patrocinato dalla Presidenza della Regione Calabria), che è testimonianza di una approfondita ricerca iconografica su varie tematiche riguardanti l’universo Calabria. «Padre e figlio intenti a fermare momenti e figure del mondo contadino e rurale e artigianale, più con l’occhio dell’anima che con la macchina fotografica» come ha scritto Alberto Frattini. Consolidata la collaborazione dei Di Cola con il professore Ottavio Cavalcanti, il quale ha curato in passato una mostra su “Alimentazione e prodotti tipici della Calabria”, nonché alcuni volumi in sede di stampa. Le fotografie presentate testimoniano una ricerca per immagini iniziata nel 1960 e documentano il senso profondo della terra di Calabria - archeologia, paesaggi, flora, fauna, centri storici, usi costumi - attraverso quasi mezzo secolo. «Un arco sbrecciato, una scalea corrosa, un androne ricco solo d'erbe inselvatichite, una maschera o un antico gesto legato a mestieri in via d'estinzione, sondati - scrive Salvatore Scarpino in Campagna e contadini tra Otto e Novecento - con lo scandaglio-sonar di Di Cola riversano segni precisi e netti, una storia, che è sempre storia d'uomini, come si sa. Di Cola non ferma i propri soggetti, li spia e li offre ancora vivi. Di fronte ai suoi lavori, anche in tempi d'inflazione visiva, è il caso di aprire gli occhi e di lustrarseli.
Come in un prezioso "Album di famiglia", Cesare e Giuliano Di Cola hanno fissato, con la ben nota impareggiabile maestria, visioni meravigliose di quella Calabria che Leonida Repaci descrisse uscita dalle mani di Dio "più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa azzurra e degli arcipelaghi giapponesi". E lo hanno fatto raccogliendo immagini tutte originali, in un percorso ideale che muove dal Pollino all'Aspromonte e nello stesso tempo può essere reimpostato dal lettore, secondo le proprie scelte e le proprie inclinazioni. La Calabria così come oggi si presenta: con le memorie del passato spesso travolte dai ricorrenti terremoti e dall'incuria dei suoi abitanti, ma anche mirabilmente custodite in chiese, monasteri e musei pubblici; con l'incanto delle proprie tradizioni contadine ed artigiane; e soprattutto con lo splendore delle sue ricchezze naturali, che la fotografia coglie e fissa in maniera sublime. Quest'album di Visioni e memorie costituisce così con i suoi squarci di luci e di ombre un'eccezionale fonte visiva degli inizi del III Millennio. Una nuova tappa prestigiosa dei due fotografi cosentini.
(Pietro De Leo, Presidente della Commissione Cultura Stato-Regione Calabria, novembre 2003)
Lo sguardo nuovo e la memoria nella fotografia creativa di Giuliano e Cesare Di Cola
Nell'epoca segnata dall'edonismo più sfrenato e dalla folle corsa contro il tempo nell'illusione vana che sugli «attimi fuggenti» possano trionfare i deliranti sogni di eternità e onnipotenza per vivere nel vuoto pneumatico di un presente assoluto, non meraviglia il fatto che si vadano progressivamente cancellando, nelle menti e nei cuori dell'uomo-massa, le tracce di quell'arte della memoria custodita e tramandata per secoli – con alterne vicende e trasposizioni legate alla «teoria generale della conoscenza» – a partire dalla Grecia arcaica che ne aveva fatto una divinità, denominandola Mnēmosynē e considerandola madre delle Muse.Giuliano Di Cola, nei suoi oltre quarant'anni di attività, ha accumulato esperienze diverse – partendo dall'umile, ma estremamente importante, dal punto di vista formativo, mestiere del fotoreporter – che lo hanno portato, dopo aver perfezionato gradatamente le sue tecniche espressive, a ricevere ambìti riconoscimenti, partecipando a mostre collettive o esponendo soltanto proprie opere, su vari soggetti, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e, recentemente, in Brasile per onorare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Non va dimenticato, inoltre, che, nel 1984, godendo del privilegio di varcare le remote soglie dei monasteri eretti sul monte Athos, Giuliano Di Cola ha documentato – con immagini suggestive e artisticamente ineguagliabili, note ormai in tutto il mondo – le opere e i giorni delle comunità di monaci greco-ortodossi che abitano quel territorio impervio e, al tempo stesso, ameno.
Da un decennio Giuliano Di Cola condivide a pieno titolo i suoi meriti con il figlio Cesare che ai segreti della tecnica e dell'arte adoperate dal padre ha saputo aggiungere – facendoli con essi creativamente interagire mediante un'assidua e proficua sperimentazione – quelli appresi ed escogitati familiarizzando con gli strumenti nuovi offerti dalla tecnologia avanzata nel campo, oltre che dell'immagine fotografica, della computer grafica, come attestano l'allestimento e la gestione, da lui effettuati, a partire dal 2001, del sito web (www.pianetacalabria.it), divenuto 'meta' di ben 120.000 visitatori all'anno e inserito nel portale degli Archivi dell'Unesco.
Applicando i criteri metodologici di uno 'sguardo' che supera il contingente, e quindi la mera registrazione del 'visibile', pur partendo dall'hic et nunc – senza alcun intento, però, di fagocitarlo e 'fissarlo' in assoluto, annullandone la carica propulsiva e maieutica che vi si può rinvenire, attraverso il classico e meccanico clic della macchina fotografica tradizionale – Giuliano Di Cola, ha, per lunghi anni, con sapienza certosina e «intelletto d'amore», ripreso , in Calabria soprattutto, immagini del mondo contadino, dell'architettura rurale, delle tecniche di coltivazione dei campi, dei prodotti tipici, dell'arte culinaria, dei riti e dei mestieri antichi, dei monumenti storici e dei reperti archeologici e del patrimonio artistico in generale, dei paesaggi montani, collinari, marini e urbani, finendo per disporre di un archivio vasto e prezioso, ritenuto, a giusta ragione, una fonte ineludibile dagli studiosi di varie parti del mondo che vi hanno fatto ricorso – e continuano a ricorrervi – per ricerche attinenti ai vari campi dello scibile umano (spaziando dall'archeologia all'architettura, dalla storia dell'arte alla storia tout court, dalla letteratura all'antropologia, dalla sociologia all'economia, dalla geografia fisica all'ecologia) e per supporti iconografici ad articoli, saggi o testi antologici da pubblicare su settimanali, riviste specialistiche, guide, manuali e volumi monografici.
Giuliano Di Cola, piuttosto che perseguire finalità 'documentaristiche' di facciata con presunzione di 'oggettività', preferisce far avvertire la presenza attiva dell'uomo e dell'artista dalla forte personalità dietro l'obbiettivo della macchina fotografica adoperata con disincanto e, quindi, senza feticismo.
In virtù di tale 'poetica', nessuna concessione fa al folklorismo di maniera e al 'color locale', anche quando – come nel caso della presente raccolta di immagini, non poche delle quali ascrivibili all'estro del figlio Cesare – il soggetto è costituito dal centro storico della città di Cosenza.
Sceglie, infatti, di resecare sistematicamente, persino dai 'bassi' dei vicoli tuttora pulsanti di vita, le figure umane, epifanicamente evocate dagli oggetti come i panni, dai colori variopinti, stesi ad asciugarsi al sole e i vasi da fiori che fanno bella mostra di sé, essendo loro attribuita una funzione ornamentale essenziale in ambienti alquanto degradati e miseri.
Walter Benjamin, nel 1931 scriveva:
[...] l'elemento decisivo per la fotografia resta sempre il rapporto del fotografo con la sua tecnica [...][1].
E, nel 1936, osservava:
[...] quando l'uomo scompare dalla fotografia, per la prima volta il valore espositivo propone la propria superiorità sul valore cultuale. Il fatto di aver dato una propria sede a questo processo costituisce l'importanza incomparabile di Atget, che verso il 1900 fissò gli aspetti delle vie parigine, vuote di uomini. Molto giustamente è stato detto che egli fotografa le vie come si fotografa il luogo di un delitto. Anche il luogo di un delitto è vuoto di uomini. Viene fotografato per avere indizi. Con Atget, le riprese fotografiche cominciano a diventare documenti di prova nel processo storico. È questo che ne costituisce il nascosto carattere politico. Esse esigono già la ricezione in un senso determinato. La fantasticheria contemplativa liberamente divagante non si addice alla loro natura. Esse inquietano l'osservatore; egli sente che per accedervi deve cercare una strada particolare [...][2].
Ebbene, senza tema di smentite, si può affermare che quella «strada particolare» è stata trovata dall'«osservatore» delle «riprese fotografiche» di Giuliano e Cesare Di Cola, a giudicare dal successo di pubblico e di critica da esse ottenuto.
I portali dei palazzi signorili, i ruderi maestosi del castello svevo carico di storia e di leggende (rievocate qui, con grazia ed eleganza, da Cesare Di Cola nel suo saggio), le botteghe artigiane e i negozi e i caffè, gli acciottolati del corso principale, il dedalo di viuzze laterali riprese di scorcio, in dettaglio e in panoramica, le ampie vedute dall'alto con i tetti assolati o innevati dei palazzi e delle case fatiscenti addossate tra loro che – come ebbe modo di scrivere con forza espressiva Fortunato Seminara nel 1982[3] – «sembrano sorreggersi a vicenda», le «erte ripide che mozzano il fiato», appaiono riprodotti in immagini ora soffuse di gradazioni chiaroscurali ora sfavillanti di luci e di colori, quasi a scandire il tempo e il ritmo delle stagioni con i riflessi sottesi degli stati d'animo cangianti anche a seconda della prospettiva e rammemoranti talvolta le atmosfere magiche e incantate del De Chirico pittore «metafisico».
Il «paesaggio dell'anima» di Giuliano Di Cola, costituendo lo 'scarto' dalla 'norma' della teoria del 'rispecchiamento' in arte – cui continuano purtroppo a rimanere naturaliter fedeli gli ultimi rappresentanti della genia degli inguaribili laudatores temporis acti – produce un provvidenziale vero e proprio 'spiazzamento' in chi volesse continuare ad ostinarsi – coltivando un gusto retro – a rapportare alla propria esperienza di vita e ai propri ricordi questa o quella immagine, ricondotta invece a emblemi o simboli di una 'condizione umana', e pertanto a valori universali.
E ciò avviene grazie a un graduale processo di fascinazione che la potenza di rappresentazione e reinvenzione del reale genera con forza d'urto dirompente dopo il benefico effetto iniziale di contrasto e opposizione provocato dall'immediato mancato appagamento dell'orizzonte d'attesa del fruitore.
Come spiegare, altrimenti, l'enorme successo di pubblico – oltre a quello di nazionalità non italiana – di cui gode da più di due lustri, presso la vasta comunità dei calabresi non solo della diaspora, anche questo Viaggio nella Cosenza antica, giunto alla terza edizione?
[1] W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, in ID., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966, p. 68.
[2] W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 29.
[3] F. Seminara, Vecchia Cosenza, in F. Seminara – R. Mazzarelli – P. Ricca – G. D. Donato, Diario di pietre e di luce. Viaggio nella città antica di Cosenza, Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Cosenza, F7, 1982, p.14.
Luca Luciano, clarinettista e compositore partenopeo, ha contribuito al progetto Pianeta Calabria con i brani Fragment #1 e Divertimento #4.